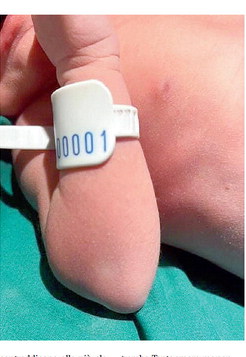
Le due sentenze della Corte costituzionale che equiparano madre biologica e “intenzionale” ma che escludono quelle single mettono di fronte all’urgenza di chiarire cosa occorra davvero ai piccoli che nascono dall’esclusione di una figura genitoriale.
Due sentenze nello stesso giorno sulla legge 40: le ha depositate il 22 maggio la Corte costituzionale per rispondere a due quesiti, corrispondenti ad altrettanti giudizi di legittimità sollevati da tribunali territoriali su casi complessi di “genitorialità in provetta”: il bambino nato da una donna che ha fatto ricorso a fecondazione eterologa in un Paese dov’è legale la richiesta di una coppia dello stesso sesso va considerato in Italia figlio anche della compagna della madre biologica? E la madre priva di un partner può ottenere di procreare da sola un figlio concepito in laboratorio sempre con fecondazione eterologa? Nel primo caso (sentenza n.68) la Corte ha equiparato madre biologica, che ha portato in grembo e partorito il bambino concepito con seme di un “donatore”, e quella che definisce “madre intenzionale”. I giudici hanno argomentato che è interesse del minore la stabilità affettiva assicurata dalla sussistenza di un progetto genitoriale delle due donne. La sentenza sulla “mamma single” (la numero 69) ha invece dato esito opposto: la Corte ha rilevato l’assenza “programmata” della figura paterna respingendo il tentativo di dichiarare illegittima la legge 40 dove prescrive la presenza di una coppia (eterosessuale) all’origine del progetto procreativo. Due esiti che sembrano contraddirsi: il padre è infatti escluso anche nella sentenza 68. Sembra prevalere per i giudici il “dato di fatto”: il bambino concepito in vitro c’è già e ha bisogno di un contesto affidabile, mentre la madre single vuole poter accedere alla provetta. Ma allora che rilievo ha la presenza (o l’esclusione) del padre nella vita del bambino? Proponiamo qui gli interventi di una neuropsichiatra infantile e di un giurista per mettere a fuoco un giudizio informato. (F.O.)
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 8 della legge 40, e ha dichiarato sostanzialmente identici ruoli e istanze delle due madri: gestazionale e intenzionale, e in questo modo ha reso identiche cose, situazioni e contesti che di per sé non lo sono. La Consulta ha assimilato parole che descrivono situazioni e condizioni diverse, creando confusione tra le parole e le realtà che descrivono. Se madre gestazionale identifica una e una sola delle due figure materne, madre intenzionale può a buon diritto essere predicato di entrambe. Non si può certo dire, infatti, che la madre gestazionale non sia al tempo stesso madre intenzionale, mentre non è vero il contrario.
Il fatto che una delle due donne abbia dato un consenso previo alla procreazione medicalmente assistita è comunque ambiguo, perché il suo consenso riguarda l’impiego di spermatozoi che non le appartengono a nessun titolo e che non saranno utilizzati per fecondare un suo ovulo. È facile chiedersi di che tipo di consenso si tratti e a cosa corrisponda. E in questo c’è una flagrante contraddizione tra ciò che posso autorizzare, senza che mi appartenga, e ciò di cui prendo atto perché rappresenta un fatto a cui altri hanno dato il loro consenso.
La Corte costituzionale ha seguito un filo logico che sembra coerente, per cui vale la pena ripercorrerlo punto per punto, nonostante nasconda un vulnus che con il tempo mostrerà i suoi effetti contraddittori. Primo tra tutti aver legittimato l’assenza del padre e aver uniformato il ruolo delle due donne. Per semplificare la narrativa di questa sentenza così stupefacente vale la pena schematizzare tre passaggi: 1. L’attuale sentenza della Corte parte da una precedente sentenza, la n. 272 del 2017, in cui si afferma che per tutelare il bambino concepito con fecondazione eterologa occorre tutelare anche i diritti di chi si impegna ad accoglierlo, assumendosene le relative responsabilità (Tutela del nucleo familiare). 2. Nel punto 8.3 dell’attuale sentenza c’è un esplicito riferimento all’unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della intera riforma della filiazione: tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente da come siano nati, all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottati. Tutti debbono godere della stessa considerazione, per cui secondo l’attuale sentenza il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale in questione non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato (ribaltamento del nucleo familiare e omologazione dei diversi ruoli) 3. L’orientamento sessuale, secondo l’attuale sentenza, «non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali » (sentenza n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021). La sentenza sostiene che non c’è alcuna dimostrazione scientifica che metta in dubbio la capacità di una coppia omosessuale a prendersi cura di un figlio (mancanza di evidenze scientifiche documentate con procedure scientificamente rigorose).
A questo punto la figura paterna è esclusa dalla dinamica genitoriale e il quesito che emerge con prepotenza è quale sia il vero interesse del bambino. Possono madre gestazionale e madre intenzionale supplire all’assenza della figura paterna? E la dinamica tra le due figure materne è tanto più credibile quanto più sono assimilate l’una all’altra o quanto più sono differenziate? È ragionevole affermare che una madre è quella gestazionale e l’altra è la madre adottante, che per affetto e per solidarietà offre alla madre gestazionale e al figlio adottato tutte le cure necessarie a supplire alla carenza della figura paterna?
Forse nella recente sentenza sarebbe stato più chiaro e più semplice riconoscere la diversità di ruoli e condizioni tra le due donne, riconoscendo l’assenza della figura paterna, come un vulnus: avrebbe evitato forzatura e ambiguità, che contraddicono alle più elementari leggi di natura, per cui ogni bambino nasce dalla stretta collaborazione madrepadre, ma poi per vicende complesse e non sempre prevedibili, può supplire alla mancanza della figura paterna con modalità diverse di capacità di cura e di amore. Diverse e non assimilabili, ma in alcuni casi necessarie per fronteggiare situazioni impreviste e imprevedibili. La mancanza del padre riguarda una scelta delle due donne ma non il maggior interesse del bambino. La libertà di scelta è la loro, non quella del bambino, e lo stesso bambino un giorno potrebbe chiederne conto e non essere affatto d’accordo, lamentando la mancanza del padre, anche se potrebbe comunque riconoscere di essere stato amato da entrambe. Tanto amore, ma non tutto l’amore che il bambino avrebbe potuto desiderare, proprio per una specificità diversa legata alle due diverse figure genitoriali. Una richiesta che può esplodere anche tardivamente, per esempio nel momento dell’adolescenza. Il rischio dell’adolescenza è sempre in agguato, con il disagio psicologico che porta con sé, con la fatica di chi non si sente capito e si sente defraudato di un diritto che pensava gli spettasse per diritto di nascita. Negare la specificità della richiesta in quel momento, non riconoscere la peculiarità del loro disagio, può pregiudicare il bambino, il ragazzo, l’adolescente anche tardivamente. Saperlo fin da subito è un fatto di prudenza e di realismo educativo.
La recente decisione della Corte costituzionale sull’attribuzione dello status di genitore alla madre d’intenzione, che ha prestato il suo consenso alla fecondazione in provetta di un bambino nato dalla gravidanza della sua compagna, presenta una criticità ineludibile.
La categoria del cosiddetto status riguarda i diritti e i doveri nel rapporto genitore-figlio. Il ragionamento della Corte è apparentemente semplice: perché un bambino che nasce a seguito di un patto tra due donne non deve ricevere tutela e protezione da entrambe ma soltanto dalla madre naturale? Si tratta, in altri termini, secondo il ragionamento della Corte, di aggiungere, non di levare, diritti al bambino. Detta così, difficilmente si potrebbe essere contrari. Ma la situazione che crea la Corte va molto aldilà di una attribuzione di diritti al bambino: attribuisce anche diritti al genitore d’intenzione verso il figlio, come avviene appunto nella categoria degli status. Così il genitore sceglie l’indirizzo educativo del figlio, prende decisioni in tema di salute, ha il diritto di visita in caso di separazione. E il figlio un giorno avrà doveri, anche di sostegno economico, verso il genitore. Non si tratta, dunque, di ampliare meri diritti patrimoniali del figlio verso quell’adulto che con un atto di volontà ha consentito alla generazione di un bambino, ma di qualcosa di più significativo e diverso. Con l’attribuzione dello status genitoriale alla madre d’intenzione, la donna entra pienamente nella vita del minore e, nel bene o nel male, ne condiziona l’intera esistenza. Esattamente come avviene nella generazione naturale di un figlio. Ma in quest’ultimo caso è la natura biologica che occasiona diritti e doveri verso la discendenza. E la biologia prevede due distinte figure generatrici, un maschio e una femmina. Tutto questo è totalmente indifferente agli occhi del figlio, il quale nessun consenso ha prestato alla rottura di questo ordine di cose? Potrebbe un giorno rivendicare pretese giuridiche anche patrimoniali verso l’intromissione nella sua sfera personalissima di una figura biologicamente estranea alla sua generazione?
Il tema non può ridursi ad alcune asserzioni utilizzate dalla Corte: « L’interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, che debba sempre e comunque prevalere», in quanto «al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso può essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango».
In realtà l’interesse del soggetto più fragile non è mai – per definizione – un interesse tiranno. Si tratta di un interesse legato a una condizione esistenziale da tutelare sempre, proprio in ragione dell’incapacità di chi non può farlo direttamente. E giammai può essere messo in bilanciamento con interessi legati a desideri e atti di volontà. Si tratterebbe di un ribaltamento insidioso per la tutela che ogni ordinamento democratico deve apprestare prima di tutto alle persone più vulnerabili.
Il giusto richiamo della Corte alla responsabilità di chi, con il suo consenso, ha attivato una procedura di procreazione medicalmente assistita, esorbita in un orizzonte tutto adultocentrico e disvela un’altra intenzione della sentenza: non tanto e non solo riconoscere più diritti al bambino, ma assegnare anche una posizione giuridica forte nei confronti del bambino a un soggetto che ha legami affettivi con la madre. In altri termini la decisione della Corte finisce coll’andare ben aldilà di quanto si era proposta. L’obiettivo di attribuire più diritti patrimoniali al bambino si sarebbe potuto raggiungere con una sentenza “monito” idonea a indicare questa soluzione al legislatore. Ma forse la Corte ripone scarsa fiducia nella reattività del Parlamento a legiferare sulla questione. Certamente il legislatore, se volesse, potrebbe ancora fare in tempo a porre il tema dentro il perimetro normativo corretto, assecondando il giusto anelito – pur attuato oltre i confini descritti – della Corte costituzionale.
ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2025

